Indice dei contenuti
Cosa sono il piretro naturale (le piretrine) e i piretroidi? Quali sono gli insetticidi più diffusi oggi in campo agricolo e quali rischi comportano per la salute e l’ambiente? Occupandoci di agricoltura biologica non possiamo non porci queste domande. In questo articolo, quindi, concentreremo la nostra attenzione sui rischi a cui ci espongono i comuni insetticidi, purtroppo ancora molto usati in agricoltura tradizionale.
Faremo inoltre un’importante distinzione, tra i prodotti derivanti dal piretro naturale, le piretrine, il cui uso è consentito in agricoltura biologica, con determinate limitazioni, e i piretroidi, prodotti di sintesi chimica, che rappresentano gran parte dei principi attivi degli insetticidi più usati, anche con tanta leggerezza negli orti domestici.
Il piretro naturale e le piretrine

Fiori di piretro della Dalamazia
Il piretro è un fiore, appartenente alla famiglia delle Asteracee (o composite), il cui nome scientifico è Chrysanthemum cinerariifolium. Nell’aspetto è del tutto simili alle comuni margherite, anche se non ha nulla a che vedere con esse. I fiori del piretro vengono colti, lasciati essiccare e poi macinati per ottenere un insetticida naturale. L’azione insetticida è data dalle piretrine, sostanze dunque di origine vegetale, che rappresentano il suo principio attivo.
Oggi la loro coltivazione è diffusa soprattutto in paesi come il Kenya, la Tanzania e l’Australia, da dove viene esportato.
Come funziona l’azione insetticida delle piretrine
Le piretrine esplicano la loro azione insetticida per contatto. Colpiscono il sistema nervoso dell’insetto provocando prima difficoltà nel muoversi. Poi arriva la paralisi e nella maggior parte dei casi la morte.
Ed ecco il primo problema delle piretrine: gli estratti naturali del piretro, dalla forte azione insetticida, NON sono selettivi e colpiscono tutti gli insetti con cui entrano in contatto, quindi anche gli insetti utili, come gli impollinatori e i predatori naturali.
Per capire la problematicità delle piretrine possiamo operare una distinzione con un altro prodotto, che è invece molto selettivo: il bacillus thuringiensis. Quest’ultimo è infatti in grado di colpire solo alcune specie d’insetti ed essere del tutto innocuo per altre.
Altra caratteristica negativa del piretro naturale e dei suoi estratti di 1° generazione, le piretrine, è l’elevata tossicità riscontrata nei confronti degli organismi acquatici come pesci, anfibi e rettili, che non devono essere mai esposti ai trattamenti.
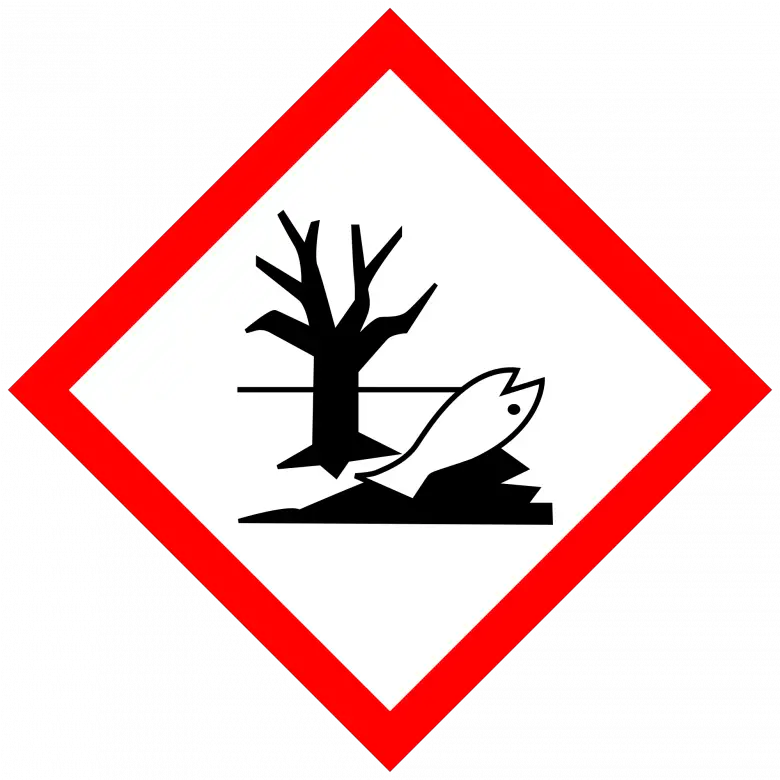
Caratteristiche positive delle piretrine
I prodotti a base di piretro naturale non sono sistemici, dunque non riescono a penetrare nella linfa delle piante. Questo limite non gli consente di esprimere la loro azione per lungo tempo.
La fotolabilità e la termolabilità comportano il rapido degrado delle piretrine alla luce solare e al calore stesso. Basta poco, infatti, perché il principio attivo si degradi del tutto e non ne rimanga traccia nell’ambiente. Per ovviare a queste caratteristiche, positive per l’ambiente ma negative per chi mette in commercio questi prodotti, le formulazioni commerciali vengono di solito addizionate con sostanze sinergizzanti. Queste sostanze sono capaci di migliorare l’assorbimento delle piretrine nell’organismo dell’insetto attraverso il rallentamento della metabolizzazione. Aumentano, inoltre, la persistenza d’azione, attraverso la riduzione della fotolabilità e della termolabilità. In questo modo le piretrine sono più stabili.
La sostanza sinergizzante più conosciuta e diffusa è il piperonil butossido (Ppbo). Questa sostanza, addizionata al piretro, ne aumenta di molto il grado di efficacia, ma allo stesso tempo anche quello di tossicità.
Nota positiva è però la NON tossicità delle piretrine nei confronti degli organismi a sangue caldo (uomo e altri animali). Questa caratteristica, purtroppo, non vale per i felini, che non riescono a metabolizzare le piretrine subendo danni neurologici.
L’utilizzo del piretro in agricoltura biologica

Ai sensi e per gli effetti del regolamento CE n. 834/2007, integrato con il CE n. 889/2008, recante le modalità di applicazione del regolamento 834/2007, nella tabella 1 allegato II, le piretrine rientrano tra le sostanze di origine animale e vegetale utilizzabili in agricoltura biologica. Il loro utilizzo è quello di antiparassitari naturali.
Tuttavia, come abbiamo appena spiegato, ci sono diversi problemi legati all’uso dei derivati di 1° generazione del piretro naturale. In particolare, tra le altre, la problematica che ci sta più a cuore è la non selettività delle piretrine. Questo perché, se vogliamo fare davvero agricoltura biologica non possiamo prescindere dalla protezione degli insetti utili dell’orto. L’azione degli impollinatori e dei predatori è infatti fondamentale in un orto bio.
Non è pensabile usare prodotti che uccidono gli insetti utili. Una coltivazione senza la presenza delle api o delle coccinelle, non si può definire biologica.
La non-selettività delle piretrine produce un ulteriore problema, che definiamo di sviluppo delle resistenze dell’insetto. Ripetuti trattamenti non fanno altro, infatti, che aumentarne la resistenza. Se si segue questa strada, si entra in un circolo vizioso che costringe a usare il prodotto in modo sempre più frequente e più intenso, con tutte le ripercussioni che ne conseguono.
Alternative al piretro
Ciò che ci sentiamo di consigliare al coltivatore biologico è di cercare altre strade per il contenimento degli insetti nocivi. La finalità dovrà essere quella di stabilire un eco-sistema compatibile con la presenza degli insetti utili.
I macerati naturali, il bacillus thuringiensis, le trappole ai feromoni, la difesa meccanica, i predatori naturali, le piante spia, ecc. ecc. sono tutte tecniche e rimedi naturali che ci consentono di attuare una strategia di difesa biologica senza alterare gli equilibri dell’ecosistema.
Piretrine e piretroidi, ulteriori informazioni
A questo punto la nostra trattazione sul piretro e i suoi derivati naturali, ovvero le piretrine, potrebbe interrompersi qui. Ci sentiamo in obbligo tuttavia di fare un ulteriore approfondimento per parlare dei piretroidi. Si tratta di una grande famiglia di principi attivi di sintesi chimica che racchiude molti dei fitofarmaci utilizzati in agricoltura tradizionale.
Quello di cui ci rendiamo conto è una facile confusione delle piretrine, che con tutti i limiti di cui abbiamo parlato sopra sono pur sempre di origine naturale e con una tossicità limitata, con i piretroidi, che nulla hanno di naturale e che rappresentano un pericolo reale per la salute dell’uomo e dell’intero eco-sistema, inteso nel senso più ampio possibile.
Cerchiamo di approfondire l’argomento per capirne qualcosa di più.
Cosa sono i piretroidi
Il piretro e i suoi estratti naturali sono usati sin dall’inizio del secolo scorso come antiparassitari naturali. Ovviamente l’efficacia risentiva delle caratteristiche proprie del piretro, cioè la bassa persistenza e l’elevata fotolabilità.
Nel secondo dopoguerra, le aziende chimiche, intuite le grandi capacità insetticide del piretro, ne modificarono la molecola. Creano quindi dei prodotti di sintesi chimica, ossia i piretroidi.
Dunque i piretroidi altro non sono che molecole, principi attivi di derivazione chimica in grado di riprodurre il meccanismo d’azione del piretro. Anzi, i meccanismi d’azione molto più incisivi e allo stesso tempo più pericolosi.
Lo sviluppo dei piretroidi
Lo sviluppo dei piretroidi può essere suddiviso in due passaggi successivi.
A partire dalla fine degli anni ’40 e fino alla fine degli anni ’60 si svilupparono i piretroidi di primo tipo (o di seconda generazione) con meccanismi d’azione del tutto simili alle piretrine, caratterizzati dall’elevata fotolabilità.
Tra questi piretroidi ricordiamo principi attivi quali:
- Alletrina
- Bioalletrina
- Tetrametrina
- Resmetrina
- Bioresmetrina
Queste sostanze sono attualmente presenti in molti insetticidi usati contro zanzare, mosche, vespe, ecc., e si trovano nelle bombolette spray, nelle polveri, nelle spiralette, negli zampironi.
Il progredire dell’industria chimica ha fatto sì che a partire dall’inizio degli anni ’70 si potesse manipolare ulteriormente la molecola del piretro naturale, ossia l’acido crisantemico. Da questo momento in poi prende vita un’ulteriore generazione di principi attivi: i piretroidi del secondo tipo (o di terza generazione).
Tra questi i più diffusi sono:
- Permetrina
- Cipermetrina
- Deltametrina
- Fenvalerato
Questi piretroidi sono molto più attivi e stabili di quelli della generazione precedente. E sono fotostabili, quindi con un’azione molto persistente, in quanto non sensibili alla luce e al calore.
Questi principi attivi li troviamo nei più comuni fitofarmaci-insetticidi in commercio contro i principali insetti dannosi dell’orto (o nei prodotti antiparassitari per gli animali domestici).
Nota bene, nessuno dei prodotti commerciali con i piretroidi come principi attivi è utilizzabile in agricoltura biologica.
Ma vediamo quali sono ora le effettive pericolosità per la salute dell’uomo e dell’ambiente. Prima di tutto indaghiamo il piretroide attualmente più diffuso, ovvero la deltametrina. Successivamente daremo un’occhiata agli studi sulla pericolosità cronica dei piretroidi che finora sono stati pubblicati.
La deltametrina, il piretroide più diffuso
Continuiamo il nostro approfondimento parlando della deltametrina, il piretroide attualmente più diffuso.
Viene sintetizzato agli inizi degli anni ’70 e successivamente brevettato nel 1981 da una nota multinazionale tedesca. Attualmente è presente in ben 21 formulati commerciali.
Basta dare uno sguardo alle foto degli orti domestici pubblicate dagli appassionati (anche sui social network), per rendersi conto di quanto questo prodotto sia diffuso anche nell’ambito della coltivazione fai-da-te.
In agricoltura tradizionale la deltametrina è utilizzata contro gli afidi, la mosca bianca, alcune cimici, bruchi, ecc. ecc. Ha però una particolare caratteristica, che ne rende l’uso assai singolare, ossia: attira gli acari, in particolare il ragnetto rosso.

Ragnetto rosso
Quindi da un lato elimina gli insetti dannosi, dall’altro ne attrae alcuni molto distruttivi per le coltivazioni. Naturalmente tutto ciò non è riportato in etichetta.
È tossico per gli organismi acquatici e per tutti gli insetti utili dell’orto. Nel 2013 l’allarme lanciato da Greenpeace fa rientrare la deltametrina tra i 7 principi attivi che andrebbero eliminati e banditi dal mercato per salvaguardare le api.
Pericoli per l’uomo e principali sintomatologie
Ma vediamo quali sono i pericoli per l’uomo, in caso si intossicazione accidentale (cosa peraltro non difficile quando si irrora il prodotto sulle piante e magari si è inesperti e non si utilizzano tutti i dispositivi di protezione personale).
Senza inventarci nulla di che, riportiamo quanto scritto in etichetta, e quindi segnalato per legge direttamente dalla casa produttrice.
Principali sintomi a livello locale:
- Grave parestesia alla pelle e agli occhi
- Irritazione alla pelle, agli occhi e alle mucose,
- Tosse e starnuti.
Principali sintomi a livello sistemico, cioè in seguito ad esposizioni prolungate e/o ripetute nel tempo:
- Dolore al petto
- Tachicardia
- Ipotonia
- Nausea
- Dolore addominale
- Diarrea
- Vomito
- Vertigini
- Vista sfuocata
- Mal di testa
- Anoressia
- Sonnolenza
- Coma
- Convulsioni
- Tremori
- Prostrazione
- Iperreazione delle vie respiratorie
- Edema polmonare
- Palpitazione
- Fascicolazione muscolare
- Apatia
Dopo questo elenco non penso ci sia molto da aggiungere. Inoltre fa riflettere il fatto che la deltametrina sia considerato tra gli operatori uno dei prodotti più sicuri in commercio. Immaginate gli altri!
Per fortuna dal 25 novembre 2015, per acquistare un prodotto del genere è necessario il certificato di abilitazione, di cui abbiamo parlato in questo articolo sui fitofarmaci.
La pericolosità cronica dei piretroidi
Per fortuna la comunità scientifica ha indagato in maniera approfondita sugli effetti cronici e a lungo periodo dei piretroidi. Anche se purtroppo le autorizzazioni di legge non collimano con le evidenze scientifiche.
Ma facciamo un passo indietro e torniamo a parlare dei meccanismi d’azione dei piretroidi.
L’azione primaria dei piretroidi (ma anche delle piretrine) si esplica nei canali del sodio della membrana cellulare. Questi sono responsabili dei fenomeni elettrici alla base delle attività degli organismi. I piretroidi si concentrano nei tessuti ad elevato contenuto lipidico, come ad esempio quello nervoso. Qui intervengono andando a disturbare la naturale trasmissione degli impulsi elettrici.
Ora, l’azione dei piretroidi è uguale negli insetti e nei mammiferi, ma nei primi è molto più efficace. Questo poiché gli insetti hanno maggiore sensibilità nei canali del sodio, dimensioni corporee evidentemente più piccole, e una temperatura corporea più bassa.
Secondo vari istituti di ricerca, tra cui il Cnr, i mammiferi sono protetti dall’azione dei piretroidi in quanto hanno un limitato assorbimento della pelle e riescono a trasformare rapidamente le sostanze, rendendole non tossiche.
Tuttavia, in caso di esposizione prolungata agli agenti chimici dei piretroidi, c’è il rischio concreto che questi si possano sedimentare nei tessuti adiposi, tra cui in primis il cervello, il cui metabolismo viene danneggiato.
Ulteriore problema in tal senso sono le altre sostanze contenute negli insetticidi, come gli organo fosforici. Quest’ultimi limitano le naturali capacità enzimatiche dei mammiferi. La contemporanea esposizione a questo tipo di agenti e ai piretroidi, aumenta la tossicità rendendola più grave e problematica.
Ulteriore aspetto critico sono le prove di tossicità in laboratorio effettuate generalmente sui topi. È noto che alcuni mammiferi sono più sensibili di altri e ci sono quindi reazioni diverse all’esposizione ai piretroidi. I topi sono noti per la loro elevata capacità di recupero cellulare.
Gli studi condotti
Gli studi condotti dal Cnrs francese e dall’associazione Antidote Europe, attraverso la tossicogenomica, hanno dimostrato nel tempo che molti prodotti molto usati e considerati poco tossici, hanno invece la capacità di alterare l’espressione genica, determinando danni cronici. Ad esempio il fegato del gatto è molto sensibile ad alcuni piretroidi come la permetrina. Questo principio attivo è stato eliminato dall’uso in agricoltura, però fa ancora parte di prodotti antiparassitari per i cani. I gatti che si sono trovati esposti a questo agente hanno avuto sintomatologie di avvelenamento gravissime.
Ulteriori studi condotti da agenzie governative americane come la US National Library of Medicine e la National Institutes of Health, hanno dimostrato problemi di neurotossicità sui soggetti giovani esposti ai piretroidi. In alcuni casi si è riscontrata addirittura l’induzione della morte dei neuroni, e quindi problemi cronici sul sistema nervoso centrale.
Potremmo andare ancora avanti con esempi di studi del genere, ma arrivati a questo punto ci sembra opportuno interrompere qui. Per ulteriori approfondimenti potete studiare questo documento Ispra (Istituto superiore per la protezione e ricerca ambientale), sugli effetti nocivi della profilassi contro le zanzare. Qui si spiega in maniera dettagliata l’azione dei singoli piretroidi e di tutti gli effetti nocivi sull’uomo e sull’ambiente.
Siamo giunti alla fine del nostro articolo e ci auguriamo di avervi spiegato in modo adeguato e comprensibile tutti i pericoli che si celano dietro l’uso del piretro naturale, dei piretroidi e quindi dei più comuni insetticidi.
Coltivazione Biologica è un blog indipendente che fornisce a tutti, in modo gratuito, preziose informazioni per coltivare in maniera autonoma il proprio orto utilizzando solo metodi biologici. Se i nostri contenuti ti sono utili, puoi sostenerci con una piccola donazione, così da permetterci di continuare a scrivere nuovi articoli. Grazie per il tuo sostegno.

5 commenti
Articolo molto utile, interessante ed esauriente. Non conoscevo alcune caratteristiche negative del piretro e dei piretroidi,pur sapendo della tossicità nei confronti dell’entomofauna utile, Grazie per il vostro prezioso lavoro di informazione,
Grazie a te 🙂
Cercavo documentazione relativa al comportamento da adottare relativamente ai tempi di carenza. Chi dice che il piretroide viene smaltito dalla pianta, e che quindi non si può raccogliere il frutto se in periodo di carenza, c’è chi sostiene invece che il frutto può essere raccolto e consumato dopo il periodo di carenza, perché il piretroide non entrerebbe nel circuito linfatico. Chi ha ragione? Grazie.
Mi sono imbatto nel vs articolo in quanto mi sono messo alla ricerca di informazioni sui piretroidi dopo aver appurato che il mio vicino di orto (ho in concessione un orto sociale) utilizza Teramit Plus nel suo orto e quando irrora la vite contamina alcuni vasi di fragole (circa 30 piantine) che ho posizionato in prossimità.
Dopo aver assistito ad un trattamento ed aver verificato che le fragole vengono effettivamente contaminate ho deciso di spostarle …ma per i frutti in fase di maturazione non so come comportarmi, …va buttato via tutto? Trattandosi di un unico intervento (la vite comincia ora ad emettere i primi tralci e da quello che ho capito questo è il primo trattamento che ha effettuato per proteggerla dalla Popillia Japonica) posso limitarmi ad attendere un periodo di tempo prima di consumare i frutti? … eventualmente quanto tempo sarebbe consigliabile.
Ringrazio fin da ora per i chiarimenti che vorrete comunicarmi.
Grazie
Non conosciamo con esattezza i dettagli di sicurezza relativi a questo insetticida chimico, giacché non utilizziamo questo tipo di prodotti. Dunque, per avere certezza sui tempi di carenza e raccolta, dovresti leggere l’etichetta del prodotto. In generale, il consiglio che ti diamo, è quello di parlare con in tuo vicino di orto sociale. Per definizione questo tipo di organizzazione dell’orto dovrebbe essere improntata al biologico, non è possibile che uno danneggi l’altro con prodotti chimici, di cui francamente si può fare a meno. Saluti.